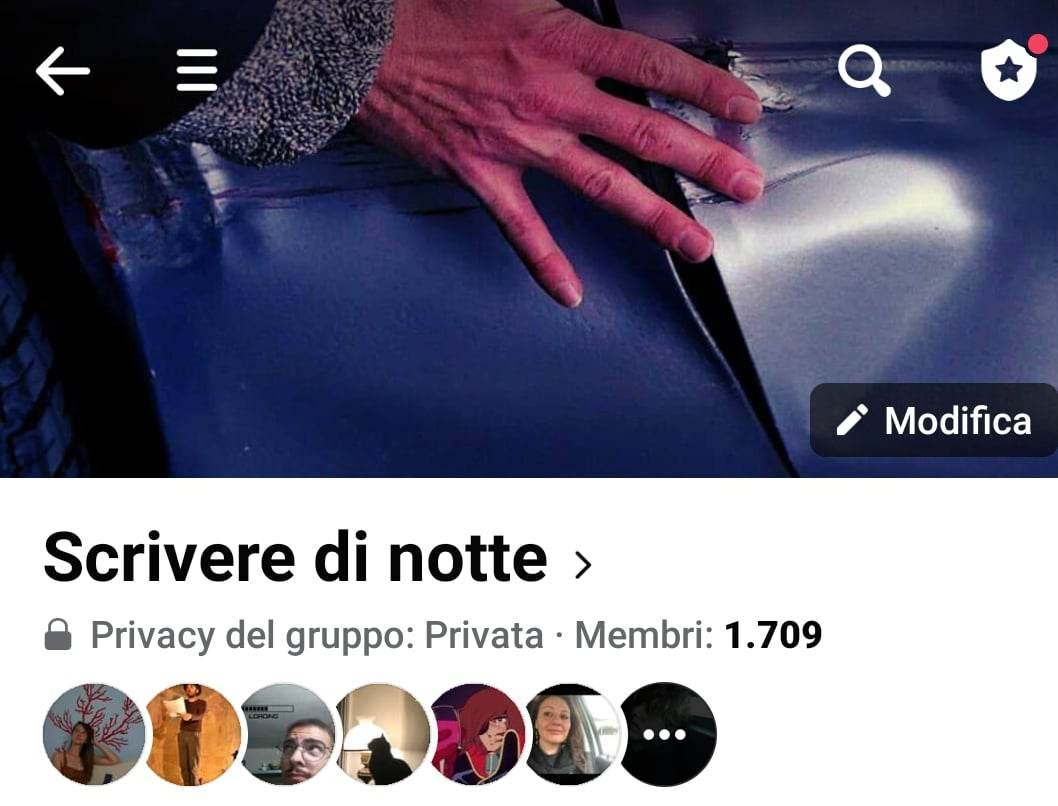Scrivere la violenza. C’è sempre, dietro, un bacio lesionato, un’illusione fatta a pezzi, quella di essere risparmiati, quella di essere amati. L’illusione, dura a morire, della propria importanza. Come per la signorina Matilde, la fragile, di appena ventidue anni, la signorina Crescenzaghi, insegnante alle serali, in una classe mista di giovani adulti e di piccoli già grandi, ragazzi con le famiglie guaste e qualcosa di rotto dentro. La maestrina delle serali, che è già morta nella prima frase di un romanzo di Scerbanenco, e da morta ha indosso un baby doll giallo, e ha un occhio pesto, i capelli strappati dalla testa, il corpo gonfio dalle botte, le costole rotte, la maestrina massacrata, pestata a sangue, il reggiseno appeso alla maniglia della finestra, la gonna all’attaccapanni, morta sotto lo sguardo di Duca Lamberti. Una delle sue calze, in tasca a uno dei ragazzi. È morta, nella prima pagina del romanzo, è morta gridando, dicono. Direttore! Insegnava alle serali, una scuola alla periferia della città, a Milano, nell’aula con la lavagna piena di cose oscene, è morta, fatta a pezzi dai suoi studenti, gridando, al colmo della paura e della sorpresa.
Chi subisce la violenza, spesso, almeno la prima volta, viene colpito per prima cosa da uno stupore invincibile. Niente ci prepara allo stupore di essere come tutti gli altri, soggetti agli attacchi della vita, al rifiuto e poi a un’aggressione che mai, nemmeno se invece ce la siamo andata a cercare, sentiremo di meritare. Sopra ogni cosa resiste l’illusione dell’amore, dell’accoglienza. Il mondo in ascolto per noi, il mondo seduto in poltrona ad assistere alle gesta che messe tutte insieme compongono la nostra vita, che è importante, perché è nostra. E invece no. Quindi nel racconto della violenza, forse, non può mancare la parte che racconta la sorpresa, che è gran parte del dolore. La sorpresa nascosta nelle fondamenta di un racconto tutto nostro, in cui eravamo i soli protagonisti, in piena luce, soggetti a un lieto fine certo. La violenza non è così semplice da dire e da raccontare perché per molti la favola che viene prima, che è dentro e tutto intorno, non viene presa in considerazione. E il mistero, anche questo è una cosa che va detta, ma come? Nelle storie di Hubert Selby Jr. la violenza ha le sembianze di un mistero complesso ma anche infantile, una domanda che ognuno di noi si è posto, almeno una volta, che però porta alla morte, alla sopraffazione, alle ferite, al sangue, alla degradazione, protagonisti che vanno fuori di testa nel porsela: perché non vengo amato? Rainer Werner Fassbinder ribaltò la domanda e la trasformò in un desiderio, un proposito, anche questo assoluto e infantile: voglio solo che mi si ami. Ruth Rendell trasformò la domanda in un sogno macchinoso, in un piano perfetto e fallimentare: la morte mi ama, farò che la morte mi ami. Giorgio Scerbanenco prese questa domanda, la ficcò nella testa e nel corpo di tanti ragazzi che massacrano la loro insegnante: i ragazzi del massacro. Tutto, nella violenza, è un racconto primitivo che è stato tradito, una domanda che è un colpo fendente.
E in quel romanzo di Scerbanenco c’è un grande fragore, di insulti, oscenità, grugniti, urla, ma dentro di loro, dentro i ragazzi del massacro, solo un silenzio interno, inestinguibile. È, questo, il terzo romanzo della serie di Duca Lamberti, Duca che una volta era un medico ma poi, dopo essere stato punito per quanto c’era di buono, di giusto e di compassionevole in lui, è diventato un poliziotto. Duca dà la caccia ai criminali: mezze calzette, gente da poco, tipi nemmeno troppo svegli, ma capaci di grandi mostruosità, deboli, vigliacchi capaci di gesti ributtanti, gente fallata, da poco, criminali da due soldi che a volte commettono atrocità quasi per caso. Lui sa come stanarli, riesce a prenderli perché pensa come loro, ma soprattutto perché sa la violenza, perché sente dentro l’urto violento, il muro di aggressività contro cui forse si sono schiantati, lì dove devono essersi spezzati i legami tra loro e il mondo, proprio come in parte è accaduto a lui.
Stavolta quelli da far parlare, quelli da mettere dentro, sono i ragazzi delle serali, quelli che nella vita non combineranno mai niente, salvo uccidere. Sono loro che hanno preso la maestrina e l’hanno trasformata in un orrendo fantoccio, che l’hanno violentata e massacrata di botte, a cui hanno strappato i capelli e spezzato le costole. Sono loro, tutti loro, quelli che hanno ucciso e quelli che hanno guardato, i ragazzi che Duca interrogherà per tutta la notte nella saletta impregnata di liquore all’anice, prima di riuscire a capire chi e perché ha deciso che quella giovane donna doveva morire. La violenza spegne la luce sulle lor storie. Tutto è buio per mancanza d’amore, tutto è feroce e insopportabile, per tutti. Le mani tese non vengono afferrate, le confidenze diventano parole d’accusa, e ancora una volta ciò che muove l’orrore è la punizione che spetta al giusto, al compassionevole. Perché la compassione vera verso il prossimo è un lusso che puoi concederti fino in fondo solo quando questo se ne sta fermo e quieto sul tavolo dell’obitorio. Chi ha portato in classe la bottiglia di liquore all’anice? Chi ha bevuto? Chi ha colpito, chi è rimasto a guardare? Duca Lamberti continuerà a domandarlo ai ragazzi in una lunga terribile notte. Però lo sappiamo, lo sa anche lui, non è questo quello che importa.
“Nel silenzio pesante di tutta la classe, di tutti gli undici ragazzi che seguivano la scena, silenzio che era tanto più inquietante quanto fuori, per il continuo passaggio di tram e auto e camion, vi era frastuono, lei sputò con violenza in viso alla giovane maestra Matilde Crescenzaghi, ed era tanto quel silenzio interno, nel frastuono che veniva dalla strada, che gli undici ragazzi sentirono il sibilo spruzzante di quello sputo, e ascoltarono, ma rimasero rigidi, come rigidi erano già prima.
La fronte colpita vicino al naso dallo sputo, la signorina Matilde Crescenzaghi guardò un attimo la donna dai pesanti occhiali neri che aveva davanti, e solo un attimo dopo si coprì il viso con un braccio, senza dire nulla, psichicamente stordita dalla sorpresa, incapace perfino di gridare.”
(Giorgio Scerbanenco, I ragazzi del massacro)
***
Nel volume B di Vitamine ci sono anche in con un racconto (M.) nel quale ho voluto raccontare non tanto la violenza su una donna, ma la fantasticheria che l’ha resa possibile, e il mistero che la circonda, e l’impossibilità di mettere a tacere quella domanda che ci ossessiona tutti ma che fa morire solo alcuni di noi. Non so se ci sono riuscita. Ma ringrazio davvero chi mi ha permesso di provarci e quindi grazie a: Carlo Maria Masselli e Francesco Merlino per avermi coinvolta.
Vitamine è bellissima, la potete trovare qui:
https://www.emergenzeweb.it/prodotto/vitamine-issue-b/
Qui sotto potete leggere il mio racconto.
M.
di Emanuela Cocco
Io ti amo
dicono
i capillari sottocutanei
sedotti.
Ematomi romantici.
Contusioni sensuali.
Fibre muscolari sovrastate
dalla passione,
lì, dove l’epidermide precipita
l’orletto roseo del terrore
di baci lesionati.
Al principio dell’estate, rientrando a casa con le buste della spesa, M. venne assalita da un uomo che in seguito affermò di non conoscere e del quale non seppe dare una descrizione utile. Interrogata sull’aspetto dello sconosciuto assalitore, la donna non seppe dire altro che si trattava di un uomo. Lo sconosciuto l’aveva aggredita colpendola con una serie di calci all’addome che quasi l’avevano ridotta in fin di vita. La donna era stata trovata da una vicina, distesa davanti al portone di casa, il corpo raggomitolato, gli occhi chiusi, le mani a coprire il viso, la testa e le spalle che andavano su e giù scosse da un tremito nervoso. Tirava calci all’aria contro un nemico invisibile, che sembrava nascosto dentro di lei, nella sua pelle pesta. La donna cercava di toglierselo di dosso, raschiarlo via dalle braccia, dalla bocca spalancata, senza riuscirci. Stendeva una gamba, poi l’altra, mentre il resto del corpo restava compresso in posizione fetale. Un liquido dorato le colava lungo le gambe per poi raccogliersi in terra, in una pozza nella quale i piedi della donna, tornati a terra dopo lo scatto nervoso, affondavano con un tonfo.
Io ti voglio
dice la pelle
lungo la linea tumefatta
dall’urto
di un amplesso rosso violaceo,
o è un male fatale?
Ma prima non c’era
neanche l’ombra mortifera di un’ematopatia
solo la dedizione di pori e di creste
di annessi cutanei divelti
e inebriati.
L’agguato era avvenuto alle 12.45 in punto. La donna ne era certa perché quel giorno era in grande ritardo sulla tabella di marcia. Il marito, che lavorava in un cantiere lì vicino come carpentiere rifinito e faceva le impalcature in legno, alle 12.30 in punto di ogni giorno tornava a casa per il pranzo. Poiché M. e la sua famiglia si erano trasferiti nella nuova casa solo da due settimane e tutto le sembrava ancora nuovo e bello, la donna aveva pensato di cucinare qualcosa di diverso e si era attardata nella scelta degli alimenti. Alle 11.50, anche di questo la donna era certa perché aveva consultato l’orologio più volte, era uscita dalla bottega, nella quale aveva acquistato dei filetti di rombo surgelati, un sacco di patate novelle, del vino bianco fermo, e una confezione di sorbetto di fragola e limone. Come primo piatto, aveva riferito con dovizia di particolari, aveva già pronta in frigo una pasta fredda. Mentre si affrettava sulla via del ritorno, però, la donna si era accorta che la vaschetta di gelato era difettosa, forse bucata sul fondo, e che il gelato, insolitamente già molle e acquoso, si era disciolto in una pozza rosa che era colata sulla confezione dei filetti di pesce. Allora, allarmata, era tornata sui suoi passi e aveva provveduto a sostituire la vaschetta di gelato con delle pesche mature, con le quali aveva intenzione di preparare una macedonia. Alle 12.25 M. aveva salutato il gestore del bar accanto alla bottega, con il quale aveva parlato appena due minuti e mezzo. Altri dieci minuti di cammino le erano occorsi per percorrere la via del ritorno e i restanti cinque minuti le erano serviti a liberarsi dalle chiacchiere della nuova vicina di casa, che si era fermata per scambiare due parole con lei. La vicina di casa, M. lo ricordava bene, indossava una gonna color mandarino, lunga a balze colorate. Lo ricordava bene perché appunto della gonna avevano parlato. M. le aveva detto che le piaceva e la donna aveva rivelato di averla pagata una sciocchezza, di averla scovata in un mercatino poco distante e che, se M. ne aveva voglia, uno di quei giorni l’avrebbe accompagnata a cercarne un’altra che le piacesse. Poi si erano salutate. Alle 12.43 in punto, M. si era arrestata davanti al portone di ingresso della sua casa, abitava in un grazioso appartamento a piano terra con giardino privato all’interno di una palazzina di nuova costruzione circondata da costruzioni basse, perfettamente dipinte e dai cancelletti sempre ben oliati, e aveva cominciato a rovistare nella borsa alla ricerca delle chiavi quando, non dovevano essere passati più di due minuti, proprio davanti al portone d’entrata, protetto ai lati da due alte e fitte siepi di oleandro bianco, si era manifestato lo sconosciuto: un uomo. Di colpo l’aveva afferrata per le braccia e dopo averla gettata a terra con una spinta e trascinata dietro le siepi di oleandro, aveva iniziato a colpirla. L’aveva riempita di calci, la donna non sapeva dire quanti perché in breve aveva perso conoscenza. E questo era tutto. Interrogata sull’aspetto dello sconosciuto assalitore la donna non seppe dire altro che si trattava di un uomo. Non un passante aveva assistito al pestaggio. Gli uomini del quartiere, eccitati alla prospettiva di un’imminente battuta di caccia, offrirono il loro aiuto e assicurarono alla donna che l’avrebbero trovato e steso. M., che pure era a terra, lei sì stesa e ansimante, tirò fuori da chissà dove una risata secca in due battute, simile al rumore di accensione di un meccanismo inceppato, che subito si quietò. Un osservatore attento avrebbe potuto cogliere in quell’accenno di risata un rimasuglio di vanità femminile.
Io mi concedo
urla il corpo nudo
teso dal desiderio in un
prurito
di orifizi,
nel calore
di mucose stupefatte.
emotività coagulativa,
di teneri piccoli vasi sanguigni
invaghiti,
intorpidimento di carezze lacero-contuse
da travaso ematico,
di rosette tattili
recise.
La vicina che l’aveva soccorsa l’accompagnò al commissariato di polizia. La migliore amica della donna abitava lontano, in un'altra città e M. non aveva voluto avvisare i parenti dell’accaduto, per non preoccuparli. L’agente incaricato la accompagnò per un lungo corridoio e la fece entrare in una stanzetta spoglia con le pareti dipinte di bianco, il pavimento scuro in laminato plastico e come unica mobilia due scaffali metallici stipati di classificatori per documenti di colore azzurro e verde oliva e una scrivania in legno rovere moro, dietro la quale si intravedeva una poltrona in pelle su cui era seduta una giovane donna in divisa, occupata a digitare sulla tastiera di un portatile, poi la lasciò in compagnia della giovane donna, che la fece accomodare sulla sedia di plastica all’altro capo della scrivania. La donna le offrì un caffè o una bevanda. M. accettò un bicchiere d’acqua.
Poco dopo entrò un altro agente, che sedette alle spalle della donna. M. attese in silenzio, tenendo gli occhi fermi sul cestino posacenere che era alla sua sinistra, in attesa che la donna o il ragazzo le rivolgessero la parola. La donna le spiegò che era importante che descrivesse nei dettagli ogni scambio verbale avuto con l’aggressore. Le disse anche che se per lei era troppo imbarazzante ripetere le parole o le frasi pronunciate dall’aggressore avrebbe potuto scriverle sopra un pezzo di carta. M. riferì tutto quello che sapeva. Uscendo dal negozio aveva notato dei panni stesi al terzo piano di un appartamento nel palazzo di fronte. Erano calzoncini e magliette, tre magliette per la precisione, di una taglia minuscola, probabilmente della taglia di un bambino piccolo, di massimo due anni. Passando davanti al bar all’angolo era passata davanti a tre uomini seduti ai tavolini, che bevevano una birra e prendevano a morsi un panino. Uno di loro a un certo punto aveva messo via il panino e aveva chiesto all’altro una sigaretta. Le chiesero se l’aggressore era alto oppure no, le domandarono quali abiti indossasse e se lo avesse sentito parlare. M.ci pensò sopra.
«Dell’uomo non so nulla», rispose «ma potrei giurare di aver sentito abbaiare un cane, di piccola taglia, da dietro uno dei cancelli di una casa in fondo alla via».
Il caso venne archiviato. Le ricerche della polizia, che pure partirono, non approdarono a niente. M. finì in ospedale e ci rimase una settimana. Venne accudita dalla figlia maggiore, che le comperò le riviste con gli ultimi pettegolezzi della stagione; dal figlio minore, che andava ancora alle scuole elementari e le portò in dono disegni fatti male e colorati peggio che riuscirono a strapparle un sorriso; e dal marito, che le tenne la mano a lungo e che a lungo lei ascoltò piangere, quasi senza un motivo.
Terrore ectodermico in assenza
di scaglie e di piume
a scivolare sull’epitelio
pavimentoso
pluristratificato
cheratinizzato
di un affronto.
Terrore corneificato e denso
innervato di illusioni.
M. era una donna amabile e una volta dimessa l’intero quartiere la circondò di premure. I vicini le fecero visita e le portarono chi fiori, chi cioccolatini, chi un dolce fatto in casa. La cara amica che viveva lontano, invece, le telefonò. Tutti le rivolsero le stesse domande. Cercarono di informarsi sulla sua salute, al principio, poi tentarono di aggiudicarsi i dettagli del caso. Chi era mai quest’uomo che l’aveva quasi uccisa? E perché ce l’aveva tanto con lei? Le donne del vicinato ipotizzarono si trattasse di un amante rifiutato. La vicina di casa, in particolare, si convinse che dietro l’incidente, che quasi l’aveva privata della sua nuova amica, ci fosse una relazione extraconiugale, e domandò a M. se non temesse per l’incolumità dei suoi figli.
«Non toccherà mai i ragazzi» rispose la donna, confermando in parte i sospetti dell’altra. «Me l’ha promesso». Le altre domande non ottennero risposta.
Dopo l’aggressione, M. cercò di riprendere la solita vita e passato qualche tempo, con l’aiuto della famiglia, il sostegno degli amici e l’interessamento dei vicini, tornò quella di sempre. Dell’incidente, una volta dimessa, non fece più parola e a molti sembrò non fosse mai accaduto. La casa era perfetta come sempre, lo sguardo quieto e fiducioso della donna era rimasto lo stesso. Così le sue abitudini. Anche in famiglia non se ne parlò più.
Arrivò settembre, a breve i figli di M. avrebbero ricominciato ad andare a scuola. La figlia maggiore frequentava l’ultimo anno del liceo. Il piccolo la quinta elementare. M. si recò nella grande cartoleria poco distante da casa e acquistò quaderni nuovi, delle penne e un bell’astuccio pieno di colori a cera per il figlio piccolo. La grande ci pensò da sé. Il marito tornò al lavoro nel cantiere in cui lavorava. M. ebbe di nuovo le mattine libere. Non le dispiaceva stare sola in casa. Aveva a disposizione tutta una serie di piccoli piaceri privati che le rendevano lieta la giornata. Le piaceva pulire la casa, anche troppo, sostenevano le amiche alle quali capitava di incontrarla all’emporio dei cinesi dove si riforniva di detersivi. Il suo piccolo giardinetto era curato a meraviglia e pieno di fiori dai nomi delicati. Nei pomeriggi troppo caldi M. accudiva le sue piante spolverandone le foglie con un panno bagnato. Al mattino era possibile scorgerla al balcone a stendere i panni appena lavati. Se qualcuno andava a farle vista il pomeriggio non era raro che la sorprendesse con in mano il ferro da stiro. A M. piaceva buttare un occhio nei cortili delle case di fronte, guardare oltre in strada e vedere i passanti fare i loro giri e ascoltare le voci dei bambini dei vicini, troppo piccoli per andare a scuola, che giocavano in giardino. Le piaceva seguire il verso dei gabbiani, che proveniva dalla discarica distante qualche isolato, immaginando di essere in una località turistica vicina al mare. Amava fare colazione con una tazza di caffè e due fette di pane spalmate di margarina vegetale e marmellata ai frutti di bosco, sfogliando un settimanale femminile a cui era abbonata.
Punteggiature a placche di
parole cicatrizzate
consacrate
in ustioni.
Ti amo,
oh, ti amo,
dice la pelle.
Ma più di ogni altra cosa, la mattina, mentre era sola in casa, circondata da rumori quotidiani che le davano sicurezza, nella casa avvolta dall’aroma del caffè, il suo piacere privato, inconfessato anche alle amiche più intime, era pensare allo sconosciuto assalitore. Lo faceva con una sorta di imbarazzo, ma senza timore, e anche, sebbene non ne fosse consapevole, con un misto di orgoglio e incredulità. La figura dello sconosciuto assalitore si stagliava nella mente della donna facendola arrestare di colpo al centro della cucina, con ancora in mano lo straccio da spolvero. Una canzone di quando era ragazza, di cui non aveva mai compreso a pieno le parole in inglese, la lingua che i figli studiavano a scuola, balzava fuori intatta dai suoi ricordi. Era un pezzo in voga alla radio, cantata da un tipo alto e magro in abito scuro e camicia bianca con i capelli dritti alzati sulla fronte in un’onda seducente. Cantava questa canzone misteriosa all’interno della quale lei, allora una ragazza, riusciva a isolare appena le parole Gold, Love, Always, Thank you. Quando le riconosceva M., ai tempi una bella ragazza non troppo alta e magrolina con una folta capigliatura castana e riccioluta, le cantava con voce sicura. La donna di cui si parlava nella canzone, una donna molto amata, aveva fatto arrabbiare un uomo. Era possibile fosse così, o almeno così le sembrava. Eppure lui la ringraziava. La voce dell’uomo raggiungeva una vertigine di passione quando la chiamava amore, quando diceva d’amarla di un amore dorato che sarebbe durato per sempre, e lei, con capogiri pericolosi e inevitabili, non poteva fare a meno di precipitarvi dentro.
Rush indotto.
Papule amorose
in deliquio
da aggregazioni piastriniche
promiscue.
Ti amo e non comprendo,
dice la pelle colpita
la pelle frolla
e addomesticata.
Passato il tempo delle ricerche, agli abitanti del quartiere sembrò improbabile che lo sconosciuto assalitore dovesse tornare. Ma l’evento si ripeté. Una mattina, sempre verso l’ora di pranzo, lo sconosciuto assalitore si fece vivo con la donna. Fu proprio M. ad aprirgli la porta, convinta si trattasse del marito con il quale era solita pranzare. Invece si trattava dell’altro, lo sconosciuto: un uomo. La donna venne spinta dentro casa, l’uomo non le diede nemmeno il tempo di parlare e la colpì al viso con un pugno. M. accusò il colpo e cadde a terra. Rimase in silenzio. Non aveva domande da fare, non sapeva perché fosse in collera con lei ma sapeva bene, glielo leggeva in faccia, che nessuna parola avrebbe potuto calmare la sua furia. Anche questa sarebbe durata per sempre, come nella canzone. Non le rimaneva che aspettare, tentando di parare i colpi. E così fece. L’aggressione durò qualche minuto, il pugno dell’uomo le fece battere la testa contro il pavimento e le ruppe il setto nasale. La donna sentì il sangue colarle dal naso e riempirle la bocca di una sofferenza addomesticata. Ne riconobbe il sapore e per questo ebbe voglia di piangere, ma non lo fece. Rimase in silenzio e finse di aver perso conoscenza. Sentì l’uomo smuoverla con un piede, ma lei si mantenne immobile e quieta, finché lui perse interesse. Lo sentì dirigersi in cucina e versarsi un bicchiere d’acqua. Poi, sbirciando con la coda dell’occhio, lo vide attraversare il corridoio e raggiungere il bagno, dove restò per qualche minuto. Quando tornò in sala da pranzo, dove la donna giaceva immobile e con gli occhi chiusi, l’uomo sputò in terra e bestemmiò, poi infilò la porta d’ingresso e la lasciò sola. M. chiuse gli occhi e si lasciò andare. Quando li aprì incontrò quelli di suo marito. Occhi preoccupati e pieni di lacrime. La donna, afflosciata sul pavimento e dolorante, distolse lo sguardo. Gli occhi del marito puntati sul suo volto, occhi pieni di paura e sofferenza, le ferivano la pelle come aghi dorati. Più tardi, quando le chiesero di descrivere l’uomo che l’aveva assalita, M. rimase in silenzio. Non aveva idea di chi fosse, se fosse alto o basso, e non avrebbe potuto dire nulla del colore dei suoi capelli. Quell’uomo per lei era uno sconosciuto. Sempre da che lo aveva veduto la prima volta, le era parso un uomo senza volto e senza nome, che le entrava sotto la pelle e la dominava. Era proprio come quella canzone di cui non sapeva decifrare il significato. Lo sconosciuto era pura azione ingiustificata, un’apparizione fugace di quanto crudele e spaventoso poteva essere il mondo, e come ogni cosa crudele e spaventosa di questo mondo non aveva bisogno di un nome, o di un volto, per arrivare a lei, per raggiungerla e toccarla. Le sue motivazioni per tutti, compresa la donna che era la sua vittima privilegiata, erano avvolte dall’oscurità.
Dopo quell’episodio le aggressioni continuarono a ripetersi con frequenza costante, una volta ogni due settimane o quasi, con minore o maggiore ferocia, a seconda delle circostanze. Nessuno sapeva spiegare come né perché tutto questo continuasse ad accadere. M., ormai, non faceva che entrare e uscire dagli ospedali per poi passare a casa periodi di convalescenza più o meno lunghi a seconda delle ferite che le erano state inferte. E ogni volta, interrogata dagli amici, affermava di non conoscere l’uomo che era solita aggredirla e di non avere nessuna idea del motivo che lo spingesse a farlo. Né alla donna riuscì di spiegare come mai lo sconosciuto fosse in grado di introdursi a casa sua alle ore più impensate, perché conoscesse così bene le sue abitudini e soprattutto come fosse possibile che in nessuna occasione qualcuno lo avesse veduto aggirarsi nei pressi della sua casa. A queste domande M. non rispondeva. Dello sconosciuto sapeva solo questo: che la voleva morta, che non si sarebbe fermato finché non l’avesse uccisa, che il suo odio quanto il suo amore sarebbero durati per sempre. Del suo amore non poteva dire nulla poiché ne ignorava la causa. Cosa aveva mai escogitato questa donna magrolina e riccioluta per attirarlo a sé e avvincerlo a quel modo? Non avrebbe potuto dirlo. Senza che la donna ne capisse il motivo, il suo corpo, la sua stessa pelle, era diventato a un certo punto territorio di conquista. Lei non aveva opposto resistenza, non c’erano stati nemmeno i prodromi di una guerra. Eppure la crudeltà delle imposizioni dettate dal vincitore era stata implacabile. La pelle recava traccia di queste battaglie ma le tracce non erano indizi capaci di aiutarla a districare il mistero del conflitto e così lei aveva rinunciato a capire. Su questo si era interrogata a lungo quando viveva ancora nella vecchia casa. Anche lì, infatti, ma questo come molte altre cose era stato taciuto, lo sconosciuto assalitore non le aveva fatto mancare le sue attenzioni. Alle volte uno schiaffo, di quando in quando una spinta e una violenta scrollata di spalle, a volte un insulto urlatole in faccia all’improvviso. La prima volta in cui le era accaduto di incontrarlo, a quei tempi non era ancora sposata, era rimasta quasi paralizzata dalla sorpresa e dalla paura. Dopo averla colpita, lui le aveva confessato di amarla. Lei gli aveva creduto. La resa era stata immediata. Uno sconosciuto. Così lo aveva chiamato tra sé e sé fin dal principio. Tale era allora, quando era solo una ragazza, e tale per lei sarebbe rimasto negli anni a venire il suo assalitore. Dopo quel primo attacco, sferratole quando era solo una ragazza, lo sconosciuto era scomparso dalla sua vita per un lungo periodo. Ecco, questo M. aveva evitato di rivelarlo a chiunque l’avesse interrogata sulla faccenda. Questa sua consapevolezza che lo sconosciuto sapesse, a volte, farsi da parte e lasciarle vivere la sua vita. Alle volte per un periodo così lungo che M. arrivava quasi a dimenticarlo. Era questo il suo trucco migliore, riusciva sempre a convincerla che lui non esistesse, o che se ne fosse andato per non tornare mai più. Perché era così che andavano le cose. Lo sconosciuto andava e veniva, ma non restava mai troppo a lungo, e dopo averle fatto visita scompariva dalla sua vita come non vi fosse mai entrato. A parte le tracce lasciate sulla sua pelle, sembrava a volte che nulla fosse mai accaduto. Ma c’era dell’altro, anche questo taciuto alle amiche, e a chiunque le domandasse i dettagli della sua storia e la esortasse a fuggire lontano, a far perdere le sue tracce e a salvarsi. C’era questa ricompensa che seguiva agli attacchi dell’uomo, questa ricompensa per cui ogni cosa che le era stata tolta le veniva poi restituita a piene mani. Questa donna molto amata, dopo essere stata ferita, veniva ricoperta d’oro. E non le rimaneva altro da fare che dire: grazie. Per sempre. Gold, Love, Always, Thank You. Ma di questo M. faceva fatica a parlare.
Ferite da difesa
ramificate ecchimosi
da attaccamento.
Anche al di sotto del tessuto
molle
io ti amo,
dice la pelle
incisa
mentre attende
la sua ultima
ricompensa.
A causa dell’ostinata reticenza della donna, a poco a poco l’interesse nei suoi confronti scemò. Le visite dei vicini cominciarono a diradarsi fino a scomparire del tutto. Nessuno fece più domande. Quando, in seguito a un nuovo agguato dello sconosciuto, M. rischiò di perdere un occhio, la cara amica che viveva lontano prese il treno per andarla a trovare. Prenotò un albergo in città e le fece un’improvvisata. M. non l’aspettava e fece quasi fatica a riconoscerla tanto era cambiata; pensò, senza dirlo ad alta voce, che a vederla sembrava quasi una donna felice. La donna varcò la soglia di casa senza aspettare di essere invitata, scansò l’amica e attraversando l’ingresso quasi correndo fece irruzione nella cucina deserta. La casa era silenziosa. M. se ne stava immobile, appoggiata allo stipite, con una mano a trattenere la porta mezza aperta. Guardava l’amica come attraverso la nebbia, senza tradire alcun disappunto. L’altra allora tornò indietro, le sorrise e chiuse la porta al suo posto, con gesto deciso. M. notò le dita lunghe e affusolate dell’amica, il polso stretto e delicato dal quale partiva un braccio esile e pallido, notò che la donna non portava più la fede nuziale. Le due amiche si abbracciarono, poi, parlando e tacendo molto ognuna molte cose conosciute o immaginate della vita dell’altra, sedettero in salotto. Conversarono dei tempi andati, quando M. viveva ancora nella vecchia casa, in un’altra città, dove le due si erano conosciute. Parlarono dei figli e dei nuovi fiori piantati in giardino, così come del tempo e di una ricetta che a casa della donna felice aveva riscosso un certo successo. M. le mostrò la casa, l’amica si complimentò per le tende nuove. Giunta l’ora di pranzo, M., già affaccendata ai fornelli, dopo uno sguardo rapido all’orologio fissato in alto sulla parete di fronte, nascondendo a fatica una certa apprensione, chiese all’amica di fermarsi a mangiare. La donna rifiutò e di colpo rivelò a M. il vero motivo della sua visita. Voleva sapere.
M. aveva capito fin dall’inizio che l’amica era lì per parlare dello sconosciuto assalitore e non rimase sorpresa. Guardò ancora l’orologio, filò in camera da letto e tornò con in mano la borsetta.
«Usciamo» disse.
Le due donne varcarono la porta di casa e si affrettarono per le scale buie e silenziose. Nessuno badava a loro, gli usci delle porte erano chiusi e nell’intero stabile regnava una quiete spaventosa. Una volta fuori, oltre il portone principale, M., ora completamente immersa nella luce, vide il volto dello sconosciuto affiorare come un’escrescenza scura, indice di un’infezione che ormai era impossibile curare, nella bianchezza dorata dell’oleandro. L’uomo, notando che non era sola, si tirò indietro per non palesare la sua presenza. M. proseguì dritta con sguardo fermo e impassibile, senza tradire alcuna emozione. Ma quando furono arrivate in fondo alla via, sentendo sciogliersi tutta la sua determinazione, si fermò. L’amica la prese per un braccio e lei si lasciò guidare qualche metro più in là, per poi arrestarsi di nuovo. L’amica si strofinò una guancia con il dorso della mano, poi prese quella di M., la tenne stretta e tirò ancora un po’ a sé la donna, sentendola irrigidirsi mentre le faceva muovere appena un altro passo malsicuro verso la sua direzione. «Muoviamoci» disse, sempre in attesa che l’altra la raggiungesse e guardandosi le spalle. «Togliamoci di qui».
Mirella, ferma al suo posto con le gambe inchiodate al suolo e gli occhi socchiusi tormentati dall’implacabile riverbero del sole, sentì ogni sua forza compiere un balzo all’indietro per rifugiarsi tra le foglie glabre dell’oleandro e trascinarla via verso la bianchezza dorata in cui si affacciavano le ombre.
A inverno inoltrato, sebbene provata, M. era ancora viva, ma non lo rimase a lungo.
***
Ma che cos’è Scrivere di Notte?
Scrivere di notte è una scuola di scrittura e una video - rivista fondata e diretta da Emanuela Cocco.
Un modo di stare nel testo
Ma poi Scrivere di notte è soprattutto un modo di stare nel testo. Qualcosa che ha a che vedere con l’intensità, con la profondità e il riconoscimento.
Di cosa si parla qui sopra?
Qui si parla di scrittura, di come sono stati scritti certi libri, certi racconti, una serie, un film, un fumetto, una lista della spesa, una lettera d’amore o una resa dei conti grondante odio.
Vi racconto cosa ne penso di questa cosa che facciamo un po’ tutti, o quasi, chi meglio chi peggio, che poi si chiama scrivere, che è un po’ come la vita, senza regole, una cosa nella quale vanno bene strategie diverse per persone diverse, e atteggiamenti d’autore, e pratiche di scrittura. Niente trucchi, niente tecniche, niente fottutissime cassette degli attrezzi, per capirci.
Poi vi dico anche qualcosa al volo sugli eventi organizzati da Scrivere di Notte, sui laboratori che tengo, cose così. Ma senza esagerare.
Ogni lunedì notte.
Restiamo in contatto?
Se ti va, quindi, possiamo incontrarci qui sopra ogni lunedì notte. Oppure in giro, in questi altri posti:
Scrivere di notte (Il sito della scuola) Così sai cosa combiniamo, dove, quando, con chi (Tra poco sarà online)
Scrivere di notte (Il gruppo privato su Facebook) ci trovi video lezioni e laboratori online gratuiti e notturni. E ci trovi autori, lettori, persone simpatiche.ù
@scriveredinotte (Il canale youtube) dove sta di casa la video rivista con ospiti autori contemporanei, e lezioni di scrittura libere e gratuite.
scriveredinottee (Il profilo Instagram) Foto di libri con tatuaggio, video - lezioni
Scrivere di Notte (La pagina Facebook) varie notizie su eventi, le foto di #scrivere
Oppure scrivimi
scriveredinotte@gmail.com
Se invece vuoi saperne di più sul mio conto:
Il mio sito personale, dove trovi le cose che ho fatto e alcune di quelle che farò
Il mio profilo facebook, dove faccio gli I Ching con i libri e mostro i miei pancake
E vedersi dal vivo, guardarsi in faccia?
Si può fare. Scrivere di notte e Il Pasto Nudo organizzano SATANTANGO libero e gratuito laboratorio di scrittura un laboratorio in presenza, 1 sabato al mese con autori ospiti, presentazioni, lezioni ed esercitazioni di gruppo. Sì è gratuito. Scrivimi
Ora sai tutto. Ci vediamo una di queste notti.